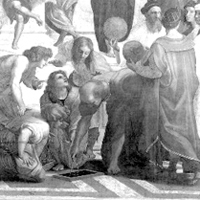 “Cultura Scientifica”: un’espressione fino a poco tempo fa generica e indifferente ai più nonostante Leonardo, Galileo, Volta, Marconi e Fermi, il loro genio, le loro intuizioni. L’Italia è un paese con un significativo patrimonio scientifico, ben conservato, ma accessibile solo agli addetti ai lavori, modestamente condiviso con la maggior parte della popolazione. Così da sempre il termine “cultura” ci rimanda al nostro umanesimo, alla nostra letteratura, alle migliori espressioni dell’arte e del diritto. Questa “cultura” ha guidato il nostro paese alla ricerca di se stesso quando, dopo l’ultimo conflitto mondiale, ha dovuto combattere un analfabetismo adulto diffuso, ricostruire la sua storia, ritrovare i suoi valori, facendosi largo tra le macerie di una guerra devastante e di una povertà dilagante.
“Cultura Scientifica”: un’espressione fino a poco tempo fa generica e indifferente ai più nonostante Leonardo, Galileo, Volta, Marconi e Fermi, il loro genio, le loro intuizioni. L’Italia è un paese con un significativo patrimonio scientifico, ben conservato, ma accessibile solo agli addetti ai lavori, modestamente condiviso con la maggior parte della popolazione. Così da sempre il termine “cultura” ci rimanda al nostro umanesimo, alla nostra letteratura, alle migliori espressioni dell’arte e del diritto. Questa “cultura” ha guidato il nostro paese alla ricerca di se stesso quando, dopo l’ultimo conflitto mondiale, ha dovuto combattere un analfabetismo adulto diffuso, ricostruire la sua storia, ritrovare i suoi valori, facendosi largo tra le macerie di una guerra devastante e di una povertà dilagante.Da allora la qualità della vita è migliorata: ora che siamo diventati più sensibili alle problematiche legate all’ambiente, che la tecnologia è entrata nella nostra quotidianità , che siamo uno dei paesi più industrializzati del pianeta ebbene ora, proprio ora, ci siamo scoperti scientificamente analfabeti. Paghiamo la mancanza di progetti, salvo qualche sporadica iniziativa individuale, a sostegno della diffusione della cultura scientifica, e l’indifferenza degli intellettuali che per troppo tempo hanno ritenuto banale, anzi una perdita di tempo, impegnarsi in attività divulgative. Fortunatamente ora ci si adopera per promuovere un generale risveglio culturale con iniziative semplici, intuitive e diversificate (ad esempio la Settimana della Scienza promossa dal Ministero, il MIUR), si cerca di interessare buona parte della popolazione adulta, ma soprattutto si cerca di coinvolgere i giovani per prepararli a raccogliere le grandi sfide del domani e ad essere protagonisti consapevoli, e quindi liberi, della propria esistenza.
In un programma di trasformazione e di qualificazione culturale della società , la biblioteca deve mettere a disposizione il suo spazio. Lo ha sempre fatto, a fianco della scuola, nelle università , anche nei momenti più bui ed oscuri della storia dell’umanità . Le grandi biblioteche generali di ricerca e conservazione, quelle di ricerca specializzate e quelle di pubblica lettura hanno sempre corrisposto all’evolversi della società assumendo i compiti dai motivi storici che ne avevano determinato la costituzione e dai fattori ambientali: primo obiettivo essere al servizio dell’utente.
Oggi poi la biblioteca può offrire servizi ancora più qualificati, perché in essa trovano posto anche documenti non cartacei (CD, VHS, DVD, etc.) e vi si utilizzano tecnologie elettroniche e telematiche (il computer, progettato per il calcolo, è un potente mezzo di comunicazione, pari, per importanza, all’invenzione della stampa).
Uno spazio aperto e vitale, non solo un luogo di conservazione e di memoria. Uno spazio in cui la circolazione delle idee sia palpabile, quasi un filo diretto ideale tra lettore e autore, oppure uno spazio in cui qualche volta l’autore, il ricercatore, lo studioso in carne ed ossa possa essere lì a confrontarsi con il lettore. Uno spazio in cui sia possibile organizzare eventi, proiettare film selezionati, dibattiti. Una biblioteca che senza travalicare troppo il suo ruolo istituzionale, deve divenire un polo di riferimento per il territorio, un punto di convergenza e di integrazione della cultura scientifica con le altre espressioni del sapere. Uno spazio senza limiti.
“Quando limiti non ci sono, e lo scopo non è circoscrivibile e definibile in termini concreti, perché lo scopo sono gli essere umani, siamo di fronte ad una biblioteca pubblica. Detto con parole antiche siamo di fronte alla medicina dell’anima” (R.M.Rilke).
Per la rubrica
Gocce di scienza
- Numero 41 aprile 2005